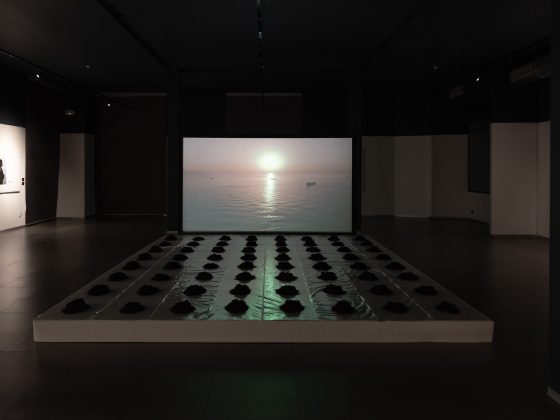Le multinazionali, così come le conosciamo oggi, nascono e crescono in un contesto plasmato dal capitalismo più spinto: massimizzazione del profitto, riduzione dei costi e una spinta continua verso la crescita illimitata. In questo modello, la sostenibilità, l’etica e perfino la salute dei consumatori sono spesso state relegate in secondo piano.
Pensiamo, ad esempio, all’industria del junk food: prodotti ultraprocessati, ricchi di zuccheri, grassi e additivi, che la scienza da anni considera dannosi per la salute. Eppure, questi alimenti continuano a essere prodotti e pubblicizzati in maniera aggressiva, perché generano fatturati miliardari e tengono in movimento intere filiere economiche. Qualcuno direbbe che è una questione di energia: i nodi stanno venendo al pettine, e ciò che fino a poco tempo fa si dava per scontato oggi viene sempre più messo in discussione.
Ma non è solo questione di cibo. Multinazionali di ogni settore – moda, lusso, beauty, tecnologia – hanno legami profondi con dinamiche politiche e geopolitiche spesso poco trasparenti. Molte di queste realtà, direttamente o indirettamente, sostengono governi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Oggi, il caso più discusso è quello del governo israeliano, accusato da più voci e organizzazioni internazionali di portare avanti un vero e proprio genocidio sotto gli occhi del mondo.
Il boicottaggio come strumento di resistenza
Davanti a questo scenario, il cittadino non è così impotente come spesso si crede. Un’azione concreta e immediata che ciascuno può compiere è il boicottaggio economico: scegliere consapevolmente di non acquistare prodotti di aziende complici o conniventi con dinamiche disumane.
La storia ci insegna che il boicottaggio funziona: dalla lotta contro l’apartheid in Sudafrica fino a esempi più recenti come quello che ha colpito Disney, che negli Stati Uniti ha perso milioni di dollari in seguito a una massiccia campagna di disdette degli abbonamenti, alimentata anche dalle critiche mosse da personaggi come Jimmy Kimmel. Sono gesti simbolici, certo, ma che possono trasformarsi in movimenti collettivi capaci di intaccare la stabilità di giganti economici.
Inoltre, boicottare significa anche consumare meglio: evitare cibi nocivi, ridurre l’acquisto di prodotti superflui, orientarsi verso aziende locali o virtuose. Un atto politico e, allo stesso tempo, un atto di cura verso sé stessi e la propria salute.
Un alleato digitale: l’app No Thanks
Per chi desidera aderire in modo pratico al boicottaggio, esistono strumenti che rendono la scelta più semplice. Tra questi, l’applicazione No Thanks rappresenta una delle soluzioni più innovative.
L’app nasce con l’obiettivo di aiutare i consumatori a identificare i brand e le aziende legati a pratiche poco etiche o coinvolti in dinamiche geopolitiche discutibili. Attraverso un sistema intuitivo, No Thanks permette di scansionare un prodotto o cercare un marchio per scoprire se appartiene a una multinazionale da boicottare. Inoltre, offre alternative più sostenibili e rispettose dei diritti umani, facilitando scelte quotidiane più consapevoli.
In questo modo, il singolo gesto di dire “no” a un acquisto si trasforma in un atto politico collettivo. Perché ogni euro speso o non speso è un voto silenzioso su quale mondo vogliamo costruire.
(a cura di Gaiazoe.life)