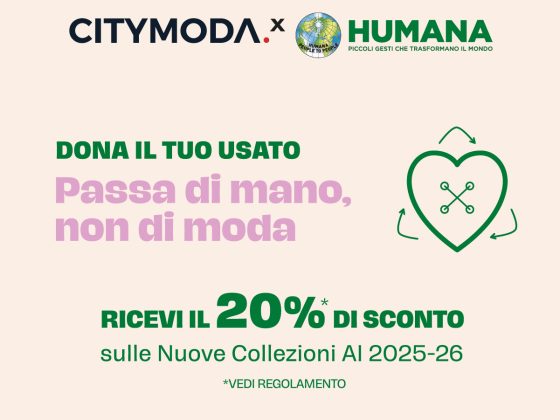Durante la Milano Fashion Week Primavera/Estate 2026, le modelle hanno sfilato indossando una nuova linea di sandali in pelle aperti in punta, firmati da Prada, una delle maison di lusso più celebrate al mondo. Tuttavia, mentre gli applausi riecheggiavano sulle passerelle, oltre 7.000 km più a est, nello stato indiano del Maharashtra, la reazione è stata ben diversa: tra gli artigiani e i rappresentanti locali si è levata una protesta accesa.
Il motivo? L’incredibile somiglianza dei sandali Prada con le Kolhapuri chappal, le calzature artigianali originarie dell’omonima città indiana. Queste scarpe, realizzate a mano da generazioni di artigiani, sono un simbolo di identità culturale, abilità manifatturiera e sostenibilità locale.
Dall’ispirazione al riconoscimento (postumo)
A seguito delle polemiche crescenti, Prada ha inviato una lettera alla Camera di Commercio del Maharashtra, in cui riconosce che la collezione “è ispirata alla calzatura tradizionale artigianale indiana, con un’eredità culturale secolare”. Un passo che, seppur tardivo, segnala una presa di coscienza.
Ma la questione rimane aperta. Perché nel materiale ufficiale dello show — dalle cartelle stampa alle descrizioni di prodotto — non vi era alcun riferimento all’India. Eppure, la somiglianza con le Kolhapuri era evidente. Così, mentre il mondo della moda applaudiva, in India montava l’indignazione.
Una delegazione di produttori locali ha persino incontrato il Primo Ministro del Maharashtra, Devendra Fadnavis, per denunciare pubblicamente quanto accaduto e intraprendere azioni legali contro Prada. I sandali della maison italiana sarebbero venduti a 1.400 dollari al paio, mentre gli originali Kolhapuri possono costare intorno ai 12 dollari nei mercati locali.
Appropriazione culturale o celebrazione?
Il caso solleva una domanda che da anni attraversa il mondo della moda: quando un marchio trae ispirazione da una cultura “altra”, dove si colloca il confine tra omaggio e appropriazione?
L’appropriazione culturale si verifica quando elementi estetici, simbolici o materiali di una cultura — spesso emarginata o colonizzata — vengono estrapolati e commercializzati da aziende o individui che non appartengono a quella cultura, senza riconoscere, rispettare o condividere i benefici con le comunità di origine.
In questo senso, la scelta di Prada appare problematica: l’assenza di una citazione iniziale, il mancato coinvolgimento degli artigiani indiani, il prezzo sproporzionato rispetto all’originale e la totale invisibilità del contesto culturale da cui è tratto il design, trasformano l’omaggio in appropriazione.
Etica ed estetica: una responsabilità condivisa
La moda è da sempre un linguaggio che attraversa i confini. Ma prendere senza restituire è un atto di colonizzazione creativa. E mentre i brand di lusso continuano a ispirarsi ai mestieri tradizionali del Sud del mondo, l’etica impone una nuova grammatica della responsabilità: coinvolgere, riconoscere, valorizzare.
Non basta dire “ci siamo ispirati”. Occorre creare alleanze, condividere valore, e perché no, restituire una parte del profitto a chi custodisce quei saperi.
Verso una moda post-coloniale e sostenibile
Il caso Kolhapuri è solo l’ultimo di una lunga lista. Dalle stampe africane alle piume indigene, dai sari ai poncho andini, la moda continua ad attingere da patrimoni culturali che rischiano di essere svuotati del loro significato.
Ma la buona notizia è che il cambiamento è possibile. Sempre più designer emergenti, piattaforme etiche e consumatori consapevoli stanno chiedendo una moda più giusta, partecipata e trasparente.
(a cura di Gaiazoe.life)